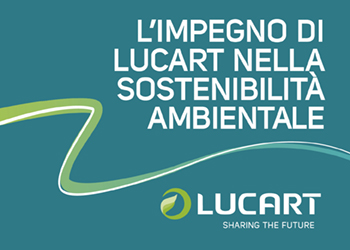E’ stata presentata a Roma l’edizione 2016 dell’Annuario dei dati ambientali dell’ ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che ha diffuso numeri allarmanti e su cui riflettere, ma soprattutto intervenire.
L’Italia è, infatti, seconda in Europa per rischi, prima di lei solo la Grecia, con sismi e frane che minacciano oltre 10mila beni culturali. Delle 900mila frane censite in Europa, ben 600mila, cioè due su tre, sono nel nostro Paese, in cui si sono contate 12 vittime causate da questo tipo di eventi e 271 episodi con danni alla rete stradale e ferroviarie, prima di tutto. Stando alle stime, 500mila italiani abitano in aree a rischio molto elevato di frane, 744mila in aree a pericolosità elevata, 1,5 milioni di persone in aree a pericolosità media e altri 2 milioni in aree a pericolosità moderata. Questo per quanto riguarda le frane. Altra minaccia seria, invece, proviene dai sismi che, a differenza del 2016, nel 2015 non hanno causato vittime e danni. L’anno scorso, anno a cui si riferisce il rapporto, i terremoti sono stati 1963, di cui solo due di magnitudo elevate, pari a 4,7 e 4,5 ed epicentri molto profondi. Tra le zone più critiche della penisola, perché presentano faglie in grado di produrre rotture e/o deformazioni importanti c’è la Calabria tirrenica, la Sicilia orientale, la catena appenninica centro-meridionale e il Friuli-Venezia Giulia.
Notizie negative che potevamo aspettarci visti gli ultimi eventi accaduti in Italia, ma soprattutto per le note negative relative al consumo di suolo che non accenna a diminuire. Si pensi che l’Italia è al primo posto in Europa per perdita di suolo dovuta all’erosione idrica, con valori di più di 8 tonnellate/ettaro per anno, quando la media europea è di 2,5. Il 5 dicembre, in occasione della Giornata Mondiale del Suolo, la Coldiretti ha divulgato dati preoccupanti proprio in merito alla perdita in Italia di oltre un quarto della terra coltivata per cola della cementificazione e dell’abbandono provocati da modelli di sviluppo sbagliati che hanno portato negli ultimi 25 anni, una riduzione della superficie agricola utilizzabile a soli 12,8 ettari.
Le buone notizie. Le acque sotterranee godono di buona salute: del 1053 corpi idrici identificati e valutati, ben il 59% è considerato “buono” sia per lo stato chimico che lo stato quantitativo. Per quanto riguarda le acque superficiali, invece, il 43% dei fiumi raggiunge l’obiettivo di qualità per lo stato ecologico e il 75% per quello chimico, mentre per i laghi il 21% raggiunge l’obiettivo di qualità per lo stato ecologico e il 47% per quello chimico. Buone notizie anche per quanto riguarda le acque costiere e quelle di balneazione, che costituiscono il 33% del totale monitorato in tutta Europa: bel il 90% di questa è risultata essere eccellente e il 4,8% buona.
Le cattive notizie. Pollice verso per la temperatura media che ha visto il 2015 come l’anno più caldo dal 1961 e negli ultimi 30 anni in Italia si registra un aumento sempre superiore rispetto a quello medio globale, rilevato sulla terraferma. Nelle acqua non va meglio, tant’è vero che gli ambienti marini, così come quelli terrestri, sono invasi da specie alloctone, come alcune specie di alghe, a causa dei pericolosi cambiamenti climatici e dell’innalzamento delle temperature.